La buona condotta del 10 marzo 2020.
10 Marzo 2020
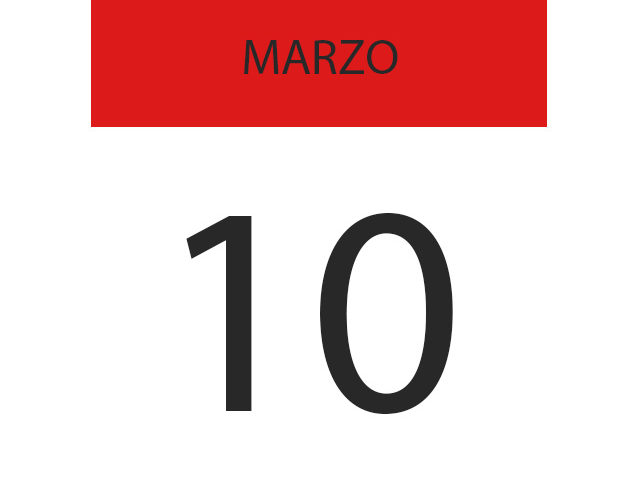
Sandro Onofri è un autore romano, scomparso all’età di 44 anni.
Ho amato moltissimo un suo libro edito postumo (2000) da Giulio Einaudi Editori, Registro di Classe. E’ stato per me un volume straordinario che mi ha accompagnato nei miei primi anni di insegnamento: uno sguardo discreto, quanto potente per usare le sue parole.
Nel 2002 è uscito Cose che succedono, una raccolta di racconti. Di questi racconti il primo credo possa fare al caso nostro. Il titolo è Quei ragazzi in silenzio come in un grande Blob. E’ un racconto breve. Avevo pensato di scannerizzarlo ed allegarlo alla pagina. poi mi sono detto che avrei potuto fare meglio, cioè dimostrare ai miei studenti il valore della copiatura.
Spesso, infatti, i miei allievi mi chiedono:
-Prof., ma perché dobbiamo copiare gli esercizi di grammatica sul quaderno? Li possiamo fare sul libro, no!
Ecco, questa pagina, copiata dal sottoscritto parola per parola, di questi tempi e con questo testo, mi sembra la risposta più efficace a quella domanda ripetuta.
COPIO:
“Un tempo consideravo la lentezza come un difetto da eliminare, quasi una malattia da curare. Quando sulle pagelle dei miei compagni, o anche sulla mia, in materie come Calcolo algebrico o Tecnica commerciale, vedevo scritta la frase “lenti nell’apprendere”, provavo una specie di brivido d’impotenza, il segno di una condanna soprannaturale alla stupidità. Più tardi, quando sono diventato a mia volta un insegnante e ho potuto rispecchiare il mio nel processo di apprendimento di certi alunni, ho avuto motivo di rivalutare e riconsiderare anche la gravità dei miei ritardi di scolaro. Perché non c’è dubbio che la maggior parte degli alunni ritardatari, quando arrivano alla comprensione di un concetto o di un contenuto, lo fanno loro profondamente. E anzi, mi sono reso conto che il loro ritardo è causato proprio da un istintivo rifiuto di una forma superficiale di comprensione.
Mi è rimasto, però, ugualmente dentro qualcosa di incompiuto, che sentivo bisogno di chiarire. Non ho mancato di leggere tutto ciò che mi capitava fra le mani riguardo al “tardare” e al “trattenersi” come forma diversa di conoscenza; a cominciare dalle pagine sui giardini di Adone nel Fedro di Platone, fino a La scoperta della lentezza di Sten Nadolny e al Saggio sulla stanchezza di Peter Handke. Eppure, anche dopo quelle letture, è rimasto un qualcosa di non chiarito, e il “fare tardi”, l’allungare il tempo” ha continuato per molto tempo ad assumere una connotazione di non centralità, di perdita.
Sarà perché vengo da una famiglia di artigiani, ma sono stato educato a considerare le pause non semplicemente come una convenienza e un lusso, ma come una necessità. Un imperativo imposto da mio padre nel metodo di rilegatura dei libri è la pausa dopo ogni fase di lavorazione: “Interrompi, accenditi una sigaretta, fai quello che vuoi, ma fermati a guardare quello che hai fatto. Devi solo guardare. È il libro che ti dice quello che va e quello che non va. Se non ti fermi, non te ne accorgi”.
Qualche tempo addietro ho letto su “l’Unità” un’intervista a Mario Soldati riguardo all’emergenza causata dalla carenze di sigarette dell’ultimo periodo. Soldato, fumatore incallito che fra un sigaro e l’altro è arrivato all’età di ottantatré anni alla faccia di tutti gli iettatori antifumo, diceva che il sigaro è per lui indispensabile per scrivere. Perché il sigaro inevitabilmente si spegne, ed è proprio in quella pausa in cui si cercano i cerini sul tavolo, nascosti magari sotto chissà quale pila di fogli, è in quella perdita di tempo che nasce l’idea. E di questo sono convinto anch’io. Gli stimoli nascono nei silenzi, nelle interruzioni, in quelle pause che la vita si prende fra un fatto e la sua continuazione.Il fascino che ha su di me la lentezza è legato ad un’immagine precisa. Quando ero ragazzino c’era il suono di una sirena che, a mezzogiorno e mezzo in punto, annunciava la sosta per il pranzo nella fabbrica vicino a casa mia. Il rumore delle macchine s’interrompeva e gli operai cominciavano ad uscire a piccoli gruppi sul piazzale davanti alla fabbrica, disordinatamente. Si sedevano sugli scalini, tiravano fuori dal giubbotto le pagnottelle, e se ne stavano lì, a godersi il silenzio e il sole, a scambiarsi qualche parola col compagno più vicino, se gli andava, e in caso contrario stando zitti. Lenta era quell’immagine di popolo, di palpebre pesanti, con i suoi colori precisi, il blu delle tute da lavoro, il piano delle strisce che delimitavano lo spazio di scarico dei camion, il giallo acceso delle pedane di legno sempre bagnate e dei metri pieghevoli che uscivano dai taschini delle giacche, e il rosso di un pallone che rimbalzava qua e là sul piazzale. Radunati a contemplare la comune voglia di stare fermi e di allungare il tempo, quegli uomini vivevano una sospensione, una situazione di attesa aperta a tutto, che costringeva alla tolleranza.
Ma non ho mai preso coscienza dei pregi della lentezza e del ritardo finché non mi è saltata agli occhi la criminale superficialità dei mucchi di puntuali solleciti che invece riempiono adesso i nostri luoghi. Tutti vogliosi di fatti, di certezze pronte e immediate.
Ci sono dei ragazzi che incontro ogni mattina alla fermata della metropolitana. Salgono all’ Eur con me e scendono quasi tutti a via Cavour. Stanno insieme, ma è come se fossero ognuno per conto suo. Impalati per tutto il tempo nella stessa posizione, con le cuffiette del walk-man infilate in testa. Sembra che non si accorgano della folla che li urta, li struscia, li aggira, li scavalca. Sono soli, in una calca di ombre che neanche vedono. Restano così, imbambolati nel cicaleccio martellante che rimbalza nelle loro orecchie e arriva fino a me, senza sosta. Io l’ho capita la legge che regola il tipo di trasmissioni che sentono quei ragazzi. E’ la legge che mi viene di chiamare della paura del silenzio. Qualsiasi radio o televisione tende ormai ad azzerare i momenti di silenzio e le pause. Non importa quello che si dice, l’importante è che si dica qualcosa.
Mi è capitato di scambiare qualche parola, di tanto in tanto, con qualcuno di questi ragazzi. E’ difficile che si svelino, perché marciano dentro le giornate con la determinazione di un battaglione di marines. Le poche volte che sono riuscito a farli parlare, mi hanno esposto la loro vita con quattro frasi. Parlano convinti, e io resto ogni volta sbalordito a vedere con quanta precisione abbiano programmato la propria esistenza. Hanno sistemato tutto, senza tralasciare il minimo particolare. Un programma senza buchi, ogni poi legato ad un altro poi, come la trasmissione che gli scornacchia nelle orecchie ogni mattina. Una chiarezze di idee che non concepisce nuvole. Un chiarore accecante. E a dare un valore definitico al loro discorso ci sono i muri quadrati delle fronti, posati sui marciapiedi belli robusti delle sopracciglia che nascondono gli occhi lontani e sempre fermi, tutti uguali. “Nella vita contano solo i fatti, signore. Solo i fatti, e tutto il resto è inutile”. E a questa affermazione, gli scorgo un lampo di soddisfatta rabbia nello sguardo.
Non li ho mai sentiti criticare un professore. Si lamentano, sì, delle strutture scolastiche dell’inutilità di certe materie (la Storia soprattutto), della severità di questo o quel docente, ma mai (proprio mai!) di qualcosa che presupponga uno scambio di sapere con l’insegnante, qualcosa che tradisca in loro anche la più piccola fiammella del sacro fuoco di un entusiasmo giovanile, di un innamoramento intellettuale. O di una stanchezza, della voglia sana di non fare niente. Il rapporto con i docenti è di semplice utenza: i professori fanno le lezioni e loro le seguono, tutto qui, senza nessun altro tipo di coinvolgimento. Questa è la loro vita, come eternamente davanti a uno schermo, a seguire un Blob gigantesco di dati, di notizie e di suoni. E come un Blob quei ragazzi hanno anche organizzato la settimana; avvicendando lo studio con il tennis, con le lezioni di pianoforte e, a giorni alterni, con gli hobby preferiti, questo il sofisticatissimo computer, quello l’impianto da radioamatore, l’altro semplicemente la televisione. Tutta la loro vita è così scandita e veloce, di una puntualità quasi autistica, in cui ogni buco, ogni spazio all’inattività è coperto dal cemento iniettato dalle cuffiette della radio, o col muoversi agitato e gli urli di qualche trasmissione televisiva.
Ho deciso che racconterò a quei ragazzi la prima volta che riuscirò a distoglierne qualcuno dal loro disc-jockey, la favola della lumachina bianca che attraversa un cortile, lentamente fermandosi ogni tanto come ad annusare l’aria. Durante la traversata lunghissima, il tempo cambia, dopo la pioggia scrosciante viene il sole, poi un vento polveroso. A ogni cambiamento di tempo la lumachina si ferma, come per assorbire gli elementi naturali e impregnarsi di ciò che la natura le manda: prima prende l’acqua, poi il calore, infine si lascia sballottare dalla polvere e scorticare dalle foglie secche. Quando arriva dall’altra parte del cortile, gravida di tutto il bene e di tutto il male che ha incontrato nel suo tragitto, non è più la lumachina candida che era partita, ma un essere rugoso e pieno di segni, della bruttezza bella che regala l’aver conosciuto.
E’ una favoletta così, inventata da me, forse poco efficace, che sicuramente provocherà in loro una reazione di superiore disprezzo. Ma se non gliel’ho ancora raccontata, è solo perché sono indeciso sul finale. Non so se la lumachina deve partorire un’altra lumaca o uno scarafaggio dalla corazza nera, imperturbabile ad ogni cambiamento, che si agita veloce e frettoloso sui percorsi sicuri, invisibile, e protetto dall’ombra di un immenso canyon.
Come il Maestro non conosco il finale della nostra storia, ma a questo punto non mi sembra particolarmente importante…

Il fatto di riscrivere gli esercizi dal libro al quaderno è una cosa che la maggior parte delle volte mi è servita. Per esempio quando dovevo andare ad una interrogazione, la maggior parte delle volte non studiavo molto, perché scrivendo sempre i riassunti della teoria, che facevamo in classe, le cose rimanevano nella mia testa. E’ come una canzone che ti piace molto e riascolti fino a quando non riesci a cacciarti quel ritmo dalla testa. Io penso che Sandro Onofri, con questo modo di apprendere e scrivere ci vuol far capire che fare una riflessione in più aiuti a ricordare meglio le cose. Forse ha ragione il prof. che penso che ci voglia far capire che questo “ritardo” è uno stimolo in più per avere risultati migliori da parte nostra.
Grazie. Hai compreso perfettamente.
Questa lettura è stata molto profonda, perché ci ha fatto capire che ai giorni d’oggi non si considera più il piacere di fare le cose con calma e lentezza. Noi ragazzi pensiamo solo a fare le cose senza aver bisogno di pause di riflessione, pensiamo solo ad arrivare a finire ciò che avevamo iniziato. E forse è qui che sbagliamo.
Nemmeno una virgola da aggiungere. Grazie.
Il brano ci fa riflettere sul fatto che anche i professori avevano difficoltà nel comprendere e molti di loro erano lenti.
Una cosa che mi ha incuriosito molto è stato il racconto della lumaca, la quale nonostante tutte le difficoltà (ad esempio la pioggia) continua il suo percorso. Mi è piaciuto il finale giocato sull’ossimoro BRUTTEZZA-BELLA.
La figura retorica ti vale un premio! Grazie della lettura.
Sicuramente i ragazzi di oggi stanno più in silenzio rispetto a quelli di una volta, perché adesso ci sono i telefoni e si incontrano meno. Io non mi ritengo una persona asociale perché tendo a parlare con le persone.
Più concretamente, Pedro? non riesco a capire sino in fondo il tenore del commento.
Anche io penso la stessa cosa, ormai i ragazzi girano sempre con quei cosi nelle orecchie sembrano delle mummie, e poi la cosa che mi da più fastidio è il fatto che quando si riuniscono più ragazzi per esempio al bar, in pizzeria o in un parco, non parlano più tra di loro, non scherzano. Ognuno perso nei fatti suoi. La colpa secondo me non è tanto dei ragazzi, ma anche un po’ da parte dei genitori dovrebbero educarli meglio invece di lasciargli fare ciò che vogliono.
Mi ha fatto molto riflettere la favola della lumachina bianca che attraversa il cortile: è molto bella e secondo.
Grazie della riflessione, Carmine
Per me ognuno ha i suoi tempi, non importa se una cosa viene fatta in modo veloce o in modo lento, l’importante è farla bene.
Anche se ci troviamo in una società che non ci permette più di essere lenti.
Noi pretendiamo il rispetto dei nostri tempi… a patto di non nascondersi dietro la nostra mancata volontà. Grazie.
La lettura di questo testo ha scaturito in me questo pensiero: la pausa, la lentezza che questo tempo ci consegna, ci porta a comprendere che la vita non è fatta solo di corse, affanni e orari… anche le pause possono contenere tanto. Questo periodo di lentezza mi fa riflettere su tante cose che prima non facevo.
Riflettere. E’ questo il tempo.
La lentezza ai giorni d’oggi è vista negativamente perché viviamo in un mondo che ci vuole molto efficienti in tutto e quindi si cresce con questa educazione del fare veloce: anche le informazioni viaggiano in maniera veloce e si investe ancora in questa direzione (vedi la tecnologia 5g). La lentezza, secondo me, ha però anche un suo lato positivo: trattenersi nelle cose ci permette di comprenderle meglio e farne nostri i contenuti. La lentezza inoltre potrebbe favorire anche il silenzio e la riflessione in contrapposizione al rumore che riempie le nostre giornate. Sicuramente questo periodo che stiamo vivendo è fatto di lentezza che è anche piacevole, a cominciare dai momenti di condivisione in famiglia. Forse questo virus un insegnamento potrà darcelo, apprezzare le cose più semplici, valorizzare i rapporti umani e tutto ciò che diamo per scontato.
Grazie, Gabriele. Mi pare un’ottima riflessione. Buona giornata.
Credo che dovremmo seguire tutti l’esempio della lumachina , fermarci quel tempo che serve e prendere una decisione per partire bene!
Siamo fermi, Valeria… usiamo bene questo tempo. Grazie della lettura.
Leggendo il racconto di Sandro Onofri, non posso fare altro che interpretare ciò che ha scritto come una sacrosanta verità: spesso noi giovani abbiamo troppa fretta di fare tutto, vedendo la lentezza e la calma quasi con disprezzo, come una perdita di tempo. Eppure fermarci a guardare ciò che stiamo facendo nella nostra vita con calma, e riflettendo sui nostri errori per imparare da essi o se possibile ripararli, è molto spesso una cosa utile e necessaria. Per riassumere ciò che voglio esprimere, e ciò che secondo me il brano in questione vuole farci capire mi permetto di citare un vecchio proverbio che quasi sicuramente tutti conosciamo: chi va piano, va sano e va lontano!
Ottimo monito. Grazie.
Secondo me noi giovani programmiamo la nostra esistenza, sistemiamo tutto creando un programma senza buchi, per non trovarci in situazioni che non ci piacciono, che non sappiamo affrontare. Se in quei momenti di silenzio, che tanto temiamo, non abbiamo le cuffiette ci sentiamo non protetti, è come se le cuffie siano lo scudo che ci protegge dai pericoli. Invece dovremmo comportarci allo stesso modo della lumachina, che nonostante sia fragile e piccina affronta il vento, la pioggia e il sole.
Grazie, Chiara. Un commento icastico ed illuminante.
Credo che la pausa sia molto importante nelle nostre vite. Ognuno ha diritto di viverla in modo diverso.
Fermarsi e ascoltare quello che succede, mentre fuori c’è finalmente silenzio.
Questo post mi fa capire che la pausa è molto importante, la pausa si può trovare attraverso una distrazione. Ci si distrae in modo diverso.
Distrazione e pausa. Da approfondire. Grazie, Davide.
Dal testo che ho appena letto mi ha colpito soprattutto ciò che viene spiegato nell’intervista di Mario Soldati, dove dice che gli stimoli
si nascondono nei silenzi e nelle interruzioni, perché penso che fare ogni tanto una pausa dal lavoro sia importante per farci venire
nuove idee e più stimoli.
Certamente vero… Grazie.
È difficile spiegare cosa vuol dire davvero avere un ritardo ad apprendere un certo argomento al di là del fatto che sia banale o complesso. La vera domanda è perché nella pausa che prendiamo per ricevere e apprendere un argomento ci perdiamo in altri argomenti che talvolta, come detto nell’articolo, fanno nascere grandi idee. Non esiste il ritardo, ognuno è diverso e non si può essere convinti che tutti ricevano, analizzino e ribattano gli argomenti negli stessi tempi.
Ognuno a suo modo con i suoi tempi… senza infingimenti, però.
Questo testo mi fa capire l’importanza di soffermarsi sulle cose. La nostra vita è scandita e veloce, nel testo si evidenzia la differenza tra i nostri tempi e i vecchi tempi. Raccomanda di godersi la vita, godersi questo tempo che non ritorna più.
E’ un testo che mi è piaciuto molto, leggendolo ho capito che nella mia vita posso cambiare tante cose, basta volerlo, e di godermi il cambiamento che farò.
Buon cambiamento, Tresy!
Io spess chiedevo di non fare i riassunti o gli esercizi sul quaderno, però col passare del tempo, ho capito l’importanza dei riassunti.
Secondo me la nostra generazione e un po’ sfaticata per questo a volte non comprendiamo bene le cose che ci dicono,e pensiamo subito a finire, sacrificando la riflessione. Molte volte questo causa errori.
Grazie, Gianluca. Davvero grazie di questo pensiero. Bisogna diventare pian piano più consapevoli.
Questo brano che ho letto mi ha fatto riflettere su alcuni aspetti della nostra vita. Tra questi, un po’ come dice l’autore, la superficialità nel fare le cose. Ci fa comprendere che a volte facciamo tutto in modo automatico senza stare lì a riflettere o a guardare quello che stiamo facendo. Penso che la colpa sia soprattutto nostra, ma anche di tutto quello che ci circonda perché a volte ci fa distrarre dalle cose serie e importanti. Anche a noi capita, come ai tempi dell’autore quando, di essere assenti: con le cuffie alle orecchie e il cellulare in mano ci isoliamo e molto spesso non interagiamo nemmeno con le persone che ci stanno vicino. Penso che rispetto ai tempi passati oggi il rapporto con i prof e i metodi di studio sono molto cambiati perché oggi la scuola non è più vista come un luogo di insegnamento e rigore ma è diventata quasi un luogo familiare. Il metodo di copiare dal libro o prendere appunti o fare un riassunto è un valido aiuto non solo per ricordare meglio gli argomenti, ma anche dal punto di vista ortografico.
Grazie del commento e dell’attenzione.
Questa lettura mi ha quasi fatto scendere una lacrima, molto significativa ma più che altro davvero reale!
Leggendo mi sono resa conto di quanto una “pausa” possa aiutare, come anche “ricopiare” sia molto utile, perché rimane impresso, parlando della mia esperienza personale posso dire che tutti gli argomenti di italiano o di qualsiasi altra materia che so perfettamente sono proprio quelli dove ho preso appunti e li ho “ricopiati” sul quaderno! Ho apprezzato tantissimo questa lettura, più la leggevo e più mi appassionavo a leggerla! Questo testo ha ragioni da vendere e penso che un po’ tutti dobbiamo praticare delle pause.
Grazie della lettura, Maria.
Ho sempre pensato che scrivere gli esercizi dal libro al quaderno sia un’inutile perdita di tempo. Avendo il libro non era una cosa sensata ricopiare gli esercizi sul quaderno. Poi pensandoci bene è una cosa buona perché ci permette di fare due cose contemporaneamente cioè di fare gli esercizi e allo stesso tempo ripetere. In questo modo noi studenti ripetiamo senza rendercene conto e in certo senso ci permette di fermarci sul lavoro che dobbiamo fare.
Soffermarsi, caro Pasquale. Fermarsi sopra.
Il trascrivere gli esercizi sui rispettivi quaderni è molto utile, però molto spesso a mancare è la voglia. È vero noi ragazzi siamo troppo impulsivi prima di fare una cosa non ci pensiamo e certe volte commettiamo grandi errori, altre volte ci rinchiudiamo nel nostro mondo senza pensare a chi ci sta intorno d e spesso lo facciamo per scappare dai nostri problemi…
Chissà se l’isolamento è davvero un antidoto ai problemi? Difficile dirlo… certo comprensibile.
Questa lettura è stata molto profonda perché noi giovani pensiamo solo a fare le cose con fretta e senza ragione. La calma è un piacere piacere che non riusciamo ad esercitare.
Questo è il momento.
Questa lettura mi ha fatto riflettere sul fatto che scrivere gli esercizi sul quaderno sia molto importante perché è un modo di farci capire più gli argomenti fatti.
Grazie, Maurizio.
Le cose fatte con lentezza per noi ragazzi diventano quasi sempre noiose a tal punto da odiarle, ma poi crescendo si capisce che le cose fatte con lentezza sono sempre le migliori.
Il guaio è che bisogna aspettare di crescere!
Secondo me ognuno ha i suoi tempi. Non importa se una cosa si fa prima o dopo, l’importante è farla bene.
Parole sante, Luciano. Le sottoscrivo.
Per me bisogna fare attentamente le cose non con fretta, ma con calma perché alcune persone hanno bisogno di più tempo per fare le cose
Rispettare i tempi di tutti è un principio sacrosanto… l’importante è fare del nostro meglio. Grazie della lettura.
Ogni persona ha i suoi tempi per apprendere l’importante è riuscire a capire, meglio tardi che mai, diceva qualcuno. Sui ragazzi purtroppo è vero che la maggior parte tende ad essere asociale, isolandosi da tutto e tutti.
Io sarei più ottimista, Adolfo…
Secondo la mia opinione le differenza tra le generazioni c’è sempre stata. Questa lettura ci fa capire che ci sono persone che per fare delle cose hanno bisogno di calma e tranquillità. L a fretta è cattiva consigliera. Tempo fa non esisteva tutta questa tecnologia si aveva più tempo per parlare e soprattutto per stare insieme, ora purtroppo dedichiamo gran parte del nostro tempo attaccati ad uno schermo e dimentichiamo tutto il resto.La lumaca ci fa capire chi va piano va sano e va lontano.
Grazie del commento, Cristian
Ho pensato, all’inizio, che riscrivere gli esercizi sul quaderno era un cosa inutile, che ci avrebbe rubato tempo inutilmente, ma con il passare dei giorni ho capito che mi sbagliavo che era molto utile e riuscivo a ricordarmi le cose molto più facilmente.
Una stampella per la memoria: la scrittura.
Ogni persona ha il suo tempo una cosa va fatta bene non importa quanto tempo serve. Questo testo mi ha fatto capire che noi giovani abbiamo fretta di fare tutto e che non pensiamo prima di fare una cosa.